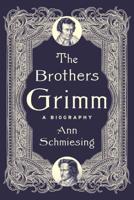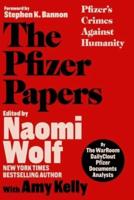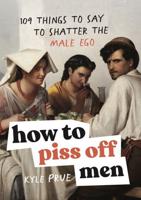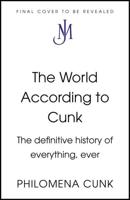Publisher's Synopsis
Questo breve saggio nasce dall'esigenza di ripercorrere e approfondire il pensiero di Herbert Marcuse, filosofo e sociologo tra i più acuti e radicali del Novecento. La sua analisi della società industriale avanzata, della razionalità tecnologica e delle forme di alienazione moderne costituisce ancora oggi uno strumento fondamentale per comprendere il nostro presente. Se l'obiettivo della filosofia è, come sosteneva lo stesso Marcuse, non solo interpretare il mondo, ma trasformarlo, allora il suo lascito teorico non può essere confinato al passato, ma deve essere riletto alla luce delle trasformazioni del XXI secolo.
Le teorie strutturate di Marcuse trovano oggi un'eco straordinaria in un contesto segnato dall'iper produttività, dalla digitalizzazione del controllo sociale e dalla crisi ecologica globale. Il capitalismo avanzato, che lui definiva un sistema capace di integrare e neutralizzare il dissenso, si è evoluto in una forma ancor più pervasiva, trasformando ogni aspetto dell'esperienza umana in merce e ogni relazione in interazione strumentale. Tuttavia, come il filosofo stesso sottolineava, la società non è una realtà immutabile: al suo interno esistono tensioni, contraddizioni e possibilità di liberazione. "Marcuse e la società del domani" non si propone di essere una semplice esposizione del pensiero marcusiano, ma una rilettura critica e attualizzata. Ogni capitolo affronta una tematica centrale della sua opera - dall'alienazione alla funzione dell'arte, dalla tecnologia come strumento di dominio alla possibilità di una nuova sensibilità rivoluzionaria - cercando di mostrarne la portata per il nostro tempo. L'intento è duplice: da un lato, restituire la complessità della sua filosofia, evitando semplificazioni e fraintendimenti; dall'altro, fornire strumenti di riflessione per chiunque voglia interrogarsi sulle dinamiche del potere e sulle possibilità di cambiamento. Marcuse non era un utopista nel senso ingenuo del termine, ma un pensatore che credeva nella possibilità di trasformare la realtà attraverso la coscienza critica e l'azione collettiva. La sua critica alla razionalità strumentale e al conformismo sociale non era fine a sé stessa, ma mirava a riaprire spazi di immaginazione e resistenza. In un'epoca in cui il dominio assume forme sempre più sofisticate - dal controllo algoritmico delle nostre vite alla spettacolarizzazione del dissenso - riprendere il suo pensiero significa riappropriarsi della capacità di mettere in discussione l'ovvio, di pensare altrimenti, di opporsi alla rassegnazione. Il testo è dunque un invito alla lettura attiva: non un tributo accademico, ma uno stimolo a usare la filosofia come strumento di lotta e di emancipazione. Se il filosofo aveva ragione nel dire che la libertà autentica non può esistere senza una trasformazione radicale della società e della coscienza, allora la sfida che ci lascia è più attuale che mai.